Per la vigilia di Natale, una rassegna di musica tradizionale di varie Nazioni d’Europa, eseguita da Vent Negru, un gruppo musicale del Canton Ticino
Mese: dicembre 2020
#7NotePerUnaNuovaEuropa #Elsass
#7NotePerUnaNuovaEuropa #SpecialeNATALE #Catalunya
#AMBIENTE #OPINIONI – LA LOTTA DI CLASSE AL TEMPO DELLA PESTILENZA – di Gianni Sartori

#VENETO #OPINIONI – Limes, Caracciolo e la battaglia di Lissa – di Ettore Beggiato
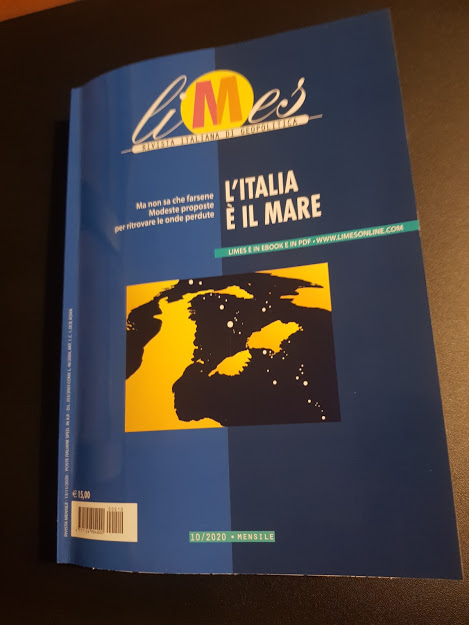
Limes, rivista italiana di geopolitica, diretta e fondata da Lucio Caracciolo, ha dedicato il numero di ottobre a “L’Italia è il mare” con il sottotitolo eloquente “Ma non sa che farsene. Modeste proposte per ritrovare le onde perdute”; all’interno diversi articoli interessanti, a partire da “Italia, penisola senza mare” di Dario Fabbri che ci ricorda “perché Londra ci volle sotto Torino, non Napoli” visto che c’è ancora qualcuno (pochi per la verità) che crede alle fanfaluche del risorgimento, a “Genova contro Venezia. Le remote radici di una rivalità permanente” di Lorenzo Noto, a Diego D’Amelio con il suo “Dal Dragone all’Aquila. Il porto di Trieste parla di nuovo tedesco”, a Lorenzo Noto che ci ricorda come “Tra Grecia e Turchia sceglie di non scegliere” che smantella inesorabilmente le certezze di chi, come me, era arciconvinto che la politica estera italiana fosse caratterizzata da immarcescibili e granitiche posizioni.
Ma è nell’editoriale del direttore Caracciolo “Non moriremo guardiani di spiaggia” che ci sono passaggi che meritano di essere sottolineati.
Gli Stati, secondo Caracciolo, si dividono in tre categorie. Quelli che usano risorse altrui per fini propri e sono le potenze, quelli che usano risorse proprie per fini altrui e sono i satelliti, e quelli che non avranno altro fine al di fuori di sé e sono gli inerti; l’Italia rischierebbe di passare da satellite a inerte.
Più avanti il politologo romano ricorda brevemente come nacque la marina del Regno d’Italia e di come fu Cavour, già ministro della Marina sarda, a fondere le varie marinerie “dedicandosi e sedare la rivalità fra Genova e Torino, con i marinai liguri, per numero preponderanti, costretti sotto l’ufficialità piemontese, percepita occupante”. Nel 1860 con l’annessione del Regno delle Due Sicilie, secondo Caracciolo, arrivò la marina meridionale che era “forse la più filo italiana delle marinerie originarie” e poi, nel 1866, arrivarono gli “ex nemici veneti che da asburgici umiliarono le tre Marine precedenti, ormai italiane, nell’infausta giornata di Lissa (20 luglio 1866”, -piaga fumante nel cuore di ogni marinaio italiano-)“.
Testuale … evito qualsiasi commento per non espormi alle rappresaglie dei nazionalisti italiani, così presenti soprattutto nella nostra Capitale Venezia …
Continuando la lettura scopro che un certo Giuseppe Garibaldi si dilettò anche nel campo della narrativa scrivendo, “Manlio romanzo contemporaneo”, nel quale sfoggiava una notevole fantasia descrivendo la rivincita di Lissa con la vittoria della Marina italiana contro le Marine austro-germaniche.
Dopo aver ricordato l’appello di Francesco Petrarca al Doge Andrea Dandolo vergato il 18 marzo 1351, affinché si arrivasse alla pace fra Venezia e Genova, l’autorevolissimo Lucio Caracciolo ritorna a Lissa, “ultima battaglia navale fra Genova e Venezia. Con i liguri a formare il nerbo dell’eterogenea flotta italiana, divisa fra siciliani-garibaldini, napoletani, sardo-liguri, guidata da un aristocratico piemontese su cui la politica scaricherà ogni colpa e i veneti dell’austriaca, gemmata dalla Ostrerreichische-Venezianische Kriegdgmarine. Beffarda leggenda vuole che colata a picco l’ammiraglia italiana, gli austro-veneti erompessero in un gagliardo VIVA SAN MARCO!”
Il maiuscolo è mio, il resto è tutto testuale …
Ettore Beggiato
#7NotePerUnaNuovaEuropa #Corsica
#7NotePerUnaNuovaEuropa #Lombardia
#KURDISTAN – UN LIBRO PER DISTRICARSI NEL “GROVIGLIO” CURDO – di Gianni Sartori
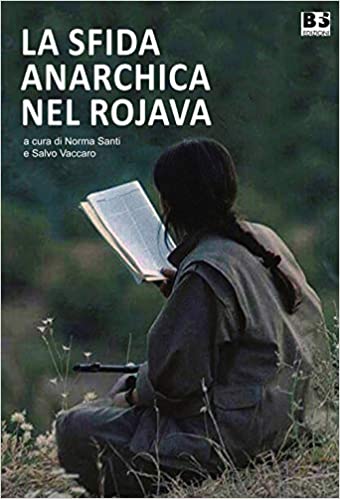
Prendiamola larga. Riguardo all’annoso dilemma se sia nato prima l’uovo o la gallina, dopo accurate ricerche storico-paleontologiche, propendo decisamente per l’uovo. L’uovo, naturalmente, di qualche piccolo dinosauro ricoperto di piume e penne che – gradualmente o con un improvviso “salto evolutivo” – produsse quello da cui nacque l’antenato ancestrale della gallina. Ovviamente si può dissentire.
Parimenti, sull’altra sofferta questione se sia nato prima il capitalismo o lo sfruttamento, le gerarchie sociali etc. propendo – come mi pare sostenga anche Ocalan –per assegnare la primogenitura alla gerarchia, al potere.
Ma – così come le galline disseminano di uova il pollaio e le immediate vicinanze – così il capitalismo ha diffuso a pioggia l’oppressione nelle sue svariate e molteplici forme.
E arriviamo al Rojava: un enigma geopolitico sospeso tra mille buone ragioni e qualche “effetto collaterale” magari indesiderato.
Tra la guerra e l’autogestione, la resistenza e l’ecologia, il rifiuto delle gerarchie e la necessità dell’autodifesa, la rivoluzione delle donne e le milizie in armi…
Un “groviglio” non indifferente.
Per districarci, orientarci, capirne qualcosa… abbiamo scandagliato la mappa realizzata da Norma Santi e Salvo Vaccaro: “La sfida anarchica nel Rojava”, pubblicato da “La Biblioteca Franco Serantini”. Un documento sull’esperimento sociale – audace e avventuroso, ma non avventuristico – intrapreso dai curdi e dagli altri popoli presenti nella regione considerata (il Rojava ovviamente, ma si parla anche del Bakur e dei Monti Qandil).
L’INTERVENTO DI RAUL ZIBECHI
Con il suo contributo Raul Zibechi affronta un enigma. Perché mai eventi di tale portata (“…il popolo in armi, il ruolo di spicco delle donne, l’autogoverno…”) vengano a manifestarsi in coincidenza con tempi duri e condizioni difficili, se non addirittura disperate (“…durante una guerra, in una situazione estremamente critica per la sopravvivenza)? Ma del resto lo stesso – più o meno – avvenne anche in Ucraina nel ’21 e in Catalunya nel ’36. I precedenti sono – relativamente – noti: accordi segreti Sykes-Picot del 1916, Trattato di Sèvres del 1920, Trattato di Losanna del 1923, Trattato di Residenza Forzata imposto dalla Turchia nel 1930, le numerose – una trentina – rivolte tra il 1920 e il 1940, l’insurrezione di Dersim nel 1938, la repressione turca degli anni ottanta e novanta…
Arrivando ai nostri giorni, lo scrittore uruguayano spiega come dalla evaporazione delle strutture statali nel nord della Siria (2011) sia derivata l’occasione per formare le Unità di Protezione del Popolo (YPG) e le Unità di Difesa delle Donne (YPJ) – le milizie che l’anno dopo avrebbero liberato Kobane e altre città. Di conseguenza, anche la possibilità per il PYD (Partito dell’Unione Democratica) e il KNC (Consiglio Nazionale Curdo) di amministrare in base ai principi del Confederalismo democratico (ossia del municipalismo libertario). E – nel gennaio 2013 – l’opportunità storica per i cantoni di Jazira, Efrin e Kobane di proclamare la loro autonomia. Tra le macerie (le “rovine” che non spaventavano Durruti e compagni) della guerra civile, i curdi avevano cercato e individuato la “loro strada attraverso l’autogoverno”. Un esempio di possibile convivenza pacifica tra curdi, arabi, aramaici, armeni, turcomanni, ceceni… Quanto al cambiamento di paradigma, non solo politico, operato dal Pkk, (per inciso: precedente alla carcerazione di Apo) secondo Zibechi costituì un elemento che doveva scatenare la “reazione furibonda degli Stati Uniti e dei loro alleati che decisero di definirlo terrorista e di perseguire il suo dirigente Abdullah Ocalan”. I fatti successivi sono noti. Espulso dalla Siria e anche dalla Russia, dopo un breve soggiorno in Italia (da fonti ben informate, in un primo momento D’Alema aveva garantito a Bertinotti l’asilo politico per il leader curdo perseguitato), Ocalan venne sequestrato – in un’operazione attribuita alla Cia e al Mossad – mentre dall’ambasciata greca in Kenya si recava in Sudafrica su invito di Nelson Mandela. Per Zibechi quindi il Pkk costituirebbe un serio problema per l’imperialismo in quanto “ora possiede una proposta per tutti i popoli del Medio oriente”. E riporta, a conferma, le “quattro critiche” allo stato-nazione mosse dal movimento di liberazione curdo. In sintesi: qualsiasi stato si fonda sul dominio di una classe, presuppone il dominio di un gruppo etnico o religioso sopra gli altri, tutti gli stati si appoggiano sul patriarcato, lo stato ha necessità di una economia produttivistica che porta alla distruzione della madre Terra.
Da cui si deduce che fatalmente “non si può farla finita con il capitalismo senza eliminare lo Stato e non possiamo liberarci dello Stato senza liberarci del patriarcato”. Amen.
Senza dimenticarsi di rimproverare ai partiti della sinistra turca, pure della sinistra rivoluzionaria, una conclamata inadeguatezza di fronte alla questione curda. Al contrario, proprio la resistenza e l’autogoverno dei curdi sia in Rojava che in Bakur, sembrano aver ridestato la sinistra turca, rimasta a lungo in difficoltà dopo il golpe del 1980.*
Tra i vari contributi – osservo – prevalgono quelli di autori statunitensi: Debbie Bookchin, Paul Z. Simons, Janeth Biehl, Marcel Cartier, David Graeber (antropologo anarchico, deceduto a Venezia nel settembre 2020), il sito itsgoingdown.
Non è detto siano esattamente i più indicati per comprendere tali dinamiche.
E’ possibile infatti che La Commune, Kronstadt, la Maknovicina, le collettivizzazioni in Catalunya e Aragona del ’36-’37 etc. (sconfitte, ma comunque fonte di ispirazione per quanto si va realizzando in Rojava) siano esperienze riconducibili più alla tormentata, secolare storia delle classi subalterne europee che alla “nuova sinistra” statunitense del secolo scorso. Magari una “prosecuzione con altri mezzi” delle jacqueries del 1300, delle guerre contadine e delle insorgenze ereticali, piuttosto che di quel “turbinio di cattivo acido, al mandarino, di amore libero e della famiglia Manson” che – come doveva ammettere Paul Z. Simon (scrittore e militante libertario, scomparso nel 2018) – contraddistinse le “comuni” nordamericane.
IL BASCO DI MURRAY BOOKCHIN: DA “VENEZIA 1984” AL ROJAVA
E comunque – lo ammetto – ci sono nordamericani e nordamericani.
Attraverso la testimonianza della figlia, veniamo informati dell’origine del rapporto tra il leader curdo Ocalan e il pensatore anarchico – statunitense, ma di origine russa – Murray Bookchin (che molti di noi ricordano, basco in testa, a Venezia nel 1984 per il convegno anarchico internazionale). Debbie Bookchin, esponente dell’Institute for Social Ecology, qui racconta di quando Murray le rivelò che “apparentemente i curdi hanno letto il mio lavoro e stanno cercando di mettere in pratica le mie idee”. Un corpo di idee che il filosofo e storico aveva denominato “ecologia sociale”. In quei giorni (aprile 2004) Bookchin padre aveva ricevuto una lettera da un intermediario (un traduttore tedesco, Reimar Heider) che scriveva a nome del militante curdo imprigionato a Imrali. Comprensibile un certo iniziale stupore, visto e considerato che fino ad allora nulla dell’ideologia del fondatore del PKK “sembrava in alcun modo assomigliare a quella di mio padre”. Invece, come spiegò Heider “Ocalan stava leggendo le traduzioni turche dei libri di mio padre in carcere e si considerava un suo bravo studente”**. Libri che Ocalan aveva potuto ottenere in carcere in quanto necessari alla preparazione di una strategia legale per la propria difesa durante il processo per tradimento. Individuando nella formazione e sviluppo dello stato-nazione (a partire dalle prime espressioni conosciute in Mesopotamia, in contemporanea con la nascita dell’agricoltura, dell’allevamento, della schiavitù, dell’oppressione delle donne…) le origini storiche del conflitto turco-curdo ed elaborando una soluzione democratica per ristabilire un rapporto di reciproco rispetto e di convivenza. Il cammino intrapreso dal PKK (fino ad approdare – nel 1998 – al Confederalismo democratico) era iniziato nei primi anni novanta (quindi, ripetiamo, prima della cattura di Ocalan) in coincidenza con la caduta del socialismo reale. Una nuova strategia che rifletteva – tra l’altro – i cambiamenti demografici avvenuti nella società curda. Dei tredici milioni di abitanti di Istanbul, ricorda la giornalista “sei milioni sono curdi” e altri quattro milioni sarebbero i curdi emigrati in Europa. Al punto che ormai, secondo Debbie Bookchin “la maggior parte dei curdi non vive in Kurdistan”. Ne consegue pertanto che “la lotta principale non è più nazionale, ma sociale”.
Una opportunità concreta di emancipazione anche per tutti quei soggetti oppressi e sfruttati che – senza esser curdi – subiscono il tallone di ferro dell’imperialismo e dei vari regimi.
Purtroppo le circostanze sfavorevoli non consentirono un incontro personale tra i due libertari. Bookchin era già anziano e con problemi di salute, Ocalan in carcere, spesso sottoposto a lunghi periodi di isolamento.
Per cui i loro contatti si limitarono a uno scambio epistolare. Nell’ultima lettera al “Mandela curdo” Murray aveva scritto: “La mia speranza è che il popolo curdo possa un giorno essere in grado di creare una società libera e razionale che permetta al loro splendore ancora una volta di prosperare. Hanno la fortuna di avere un leader del talento di Ocalan per guidarli”.
Alla morte di Bookchin (30 luglio 2006), il PKK lo volle ricordare con una dichiarazione – dettata dallo stesso Ocalan – di due pagine in cui lo definiva “uno dei più grandi scienziati sociali del ventesimo secolo”. E aggiungeva: “Ci ha introdotti al pensiero dell’ecologia sociale, e per questo verrà ricordato con gratitudine dall’umanità. (…) Ci impegniamo a far vivere Bookchin nella nostra lotta. Metteremo questa promessa in pratica come la prima società che stabilisce un tangibile Confederalismo democratico”.
LE DONNE CURDE CONTRO OGNI FORMA DI OPPRESSIONE
Particolarmente incisivo l’intervento della sociologa curda, ricercatrice al Dipartimento di Sociologia di Cambridge, Dilar Dirik. Letteralmente incisivo, in quanto – se interpretato correttamente e compiutamente – incide, penetra e scava nelle coscienze estirpandovi processi mentali consolidati, introiettati (sia dalle possibili vittime che dai potenziali carnefici).
Spiega, in sintesi, cosa sia la Jineologia “scienza e paradigma delle donne”.
Constatato e verificato che “il sistema educativo, la meccanicizzazione dei nostri pensieri e del loro flusso, sono strutturati per generare oppressione, patriarcato (…)” il movimento delle donne curde crede si debba “formulare un nuovo paradigma di lotta orientato non solamente contro qualcosa – ad esempio capitalismo e Stato – ma anche a costruire qualcosa, un’alternativa”. Per questo servono strumenti con lo stesso meccanismo della scienza, ma nello stesso tempo “contrari a come l’attuale scienza sociale lavora”. Non potendo, secondo Dilar Dirik “ usarne la stessa epistemologia e le stesse categorizzazioni”. Da cui l’esigenza di un “nuovo linguaggio” che non sia inaccessibile, astratto, di un “nuovo femminismo che possa essere coinvolgente e avere un impatto sulla vita, ad esempio, di mia nonna, della mia vicina, della donna che muore di fame per strada o che ha dieci figli”. Niente a che vedere con l’Accademia, insomma. Accademia che attualmente sarebbe in parte concepita “per tenere sotto controllo i pensieri di sinistra e radicali”. Invece con la Jineologia “noi vogliamo rendere visibile un nuovo approccio alla scienza, un nuovo paradigma su come la scienza sociale può funzionare”. Perché la scienza non può limitarsi a decifrare la società, ma dovrebbe “analizzare veramente la complessità della società stessa e i meccanismi che la rendono così com’è”. Individuando, mettendo a fuoco i collegamenti “non solo ontologici, ma anche jineologici tra gerarchia e Stato, democrazia, concetto di proprietà e il collegamento tra potere e conoscenza, e come questo impatta, soprattutto sulle donne, la natura, le comunità indigene e i poveri”.
Secondo la sociologa curda, nella stessa storia delle nazioni si ritrova “una corrente di pensiero per cui la scienza sarebbe un percorso lineare e lo Stato, il culmine dell’evoluzione e fine di questo percorso”. Ossia il dogma che lo Stato rappresenti “la civilizzazione, la fede e la più alta espressione del progresso umano”. Frutto, questa convinzione – legittimata da pensatori come Bacon e Descartes – della “divisione soggetto e oggetto, di un dualismo per cui l’uomo è soggetto mentre la natura è oggetto”.
Un pensiero dicotomico per cui “l’uomo è la mente, il soggetto, e la donna il corpo, l’oggetto; la mente è il soggetto, l’emozione è l’oggetto; lo Stato è il soggetto e la comunità, la società sono l’oggetto”.
Una dicotomia, un meccanismo di pensiero che inevitabilmente implica, stabilisce una gerarchia, in pratica “legittima la dominazione e la schiavitù, e naturalizza questi concetti facendo sì che molti movimenti – incluso in passato il PKK – siano arrivati a pensare che lo Stato significa libertà (…) convincerci che siamo oppressi perché non abbiamo uno Stato, quando in realtà è lo Stato il problema”.
Senza la pretesa di possedere “una nuova scienza rivoluzionaria” ma piuttosto di imparare ad utilizzare un “nuovo modo di interpretare la scienza, di dare valore alla conoscenza, di riarticolarla cercando di sovvertire il meccanismo gerarchico che le unisce al potere (…) rendere il flusso di conoscenza più organico e orizzontale”.
Concetti della Jineologia che acquistano ulteriore luminosità se espressi ed applicati (attraverso la partecipazione alle case delle donne, alle comuni, ai consigli, alle milizie armate…) in un contesto dove le donne hanno dovuto affrontare il “sistema di Daesh basato sul fondamentalismo che utilizza la violenza sessuale, lo stupro come motivo di propaganda”. Le donne in Rojava vedono nella scienza sociale, nella Jineologia il loro maggior strumento di autodifesa. Non nelle armi che tuttavia usano.
E la rivoluzione allora?
“Noi non crediamo – spiega Diral Dirik – che la rivoluzione sia una rottura nella storia imposta da un partito o da uno Stato poiché uno Stato non può essere fonte di giustizia. La maggior parte delle forme di oppressione negli ultimi 5000 anni della civiltà moderna sono state create dal concetto di Stato, molti meccanismi di sottomissione nascono con l’emergenza degli stati”.
E ricorda che uno dei primi stati “come concetto fu in Mesopotamia” dove vennero costruite le ziqqurat “strutturate come una piramide molto gerarchica e organizzata. In quel momento avvenne un enorme cambiamento, una transizione, una rottura storica; in quel momento sacerdoti uomini presero il monopolio della conoscenza, si costituì il primo esercito, le donne furono cancellate dalla scena e la proprietà privata cominciò a distruggere la morale e l’etica. Possiamo vedere come patriarcato, Stato e concetto di proprietà privata si alimentino a vicenda”.
Ma quasi contemporaneamente, circa 4300 anni fa, si sviluppava la prima parola che ha espresso il concetto di libertà: Amargi. Proprio quando l’oppressione diventava un sistema, un’istituzione. Da un certo punto di vista possiamo dire che da sempre coesistono “due forme di civiltà” (concetto espresso anche da Ocalan): la civiltà degli oppressori (quella dominante basata su gerarchia, dominazione, abuso di potere…) e quella democratica, alternativa rispetto alla corrente dominante, fatta da “donne, poveri, artisti, esclusi, indigeni, una civiltà naturale e comunitaria”. E – aggiungerei – ribelli, rivoluzionari, fuggiaschi, dissidenti e refrattari all’ordine costituito. Per cui potremmo anche dire che “la Jineologia rappresenta la vendetta, la nemesi della civiltà democratica contro quella dominante”. Così, lapidaria, conclude Diral Didik.
Altrettanto meritevoli di considerazione altri contributi internazionali e internazionalisti: latino-americani (l’uruguayano Raul Zibechi, già nominato), turchi (l’intervista a Devrimci Anarsiste Faaliyet) italiani (Norma Santi, Salvo Vaccaro, Eleonora Corace), curdi (oltre a Dilar Dirik, Hawzhin Azeer – citata in “Rivoluzionari o pedine dell’Impero?”), tedeschi e – presumibilmente – francesi (G.D. & T.L.).
NON PER IL MARTIRIO (MA NEMMENO PER FARSI PUBBLICITA’)
Significative le interviste a chi materialmente “si è sporcato le mani”, come i militanti integrati nelle YPG, YPJ e IRPGF. In “Non per il martirio” (a cura di Crime Thinc), oltre a spiegare le diverse motivazioni che spingono giovani turchi, europei, statunitensi…a combattere con i curdi, non si lesina qualche critica al comportamento di quelli che “provano un enorme piacere a mostrare i loro volti, posano con le armi in pugno e gongolano dei loro successi”. Spiegando che non sono mancati i casi di volontari che “hanno usato il conflitto nel Rojava per farsi pubblicità, che fa un po’ parte della logica dell’età del selfie e dei social media”. Questo ha permesso ad alcuni di loro (comunque una “piccola percentuale dei combattenti internazionali, in nessun modo rappresentativi delle motivazioni e delle azioni della maggior parte”) di “guadagnare piccole fortune scrivendo libri e usando la rivoluzione per i loro guadagni personali”. E questa, lo dicono fuori dai denti “è la peggior forma di avventurismo e di opportunismo”.
Anche per rispetto a tutti gli internazionalisti morti combattendo contro il califfato (daesh) o contro l’esercito turco. Tra cui molte compagne: Barbara Kistler, Andrea Wolf, Ivana Hoffman, Ayse Deniz Karacagil, Anna Campbell, Alina Sanchez…
Nel suo “Poscritto” Norma Santi ricorda in particolare i compagni anarchici caduti: Michael Israel, Robert Grodt, Haukur Hilarsson, Anna Montgomery Campbell (già ricordata), Sehid Sevger Ara Makhno, Lorenzo Orsetti.
Senza dimenticare altri cinque anarchici (Alper Sapan, Evrim Deniz Erol, Caner Delissu, Serat Devrim, Medali Barutcu) uccisi nella strage jihadista di Suruc (20 luglio 2015) costato la vita a 33 giovani turchi e curdi (membri della Federazione delle Associazioni dei Giovani Socialisti) che intendevano portare aiuti ai civili evacuati da Kobane.
Per concludere, un’osservazione. Tra le righe de “La sfida anarchica nel Rojava” si coglie una preoccupazione ricorrente (e comunque legittima). Ossia quanto siano veramente “rivoluzionari” i compagni curdi. Quanto realmente “anticapitalisti”. E anche quanto realmente “libertari”, se non proprio anarchici.
Preoccupazione legittima – si diceva – ma forse talvolta eccessiva. Dato che non abbiamo a che fare soltanto con una o più organizzazioni rivoluzionarie (YPG, JPG, PKK…), ma anche – soprattutto – con un popolo. Un popolo che – come altre comunità minoritarie o minorizzate (in quanto separate da artificiosi confini statali) presenti in quei territori – rischia periodicamente, se non il vero e proprio genocidio, quantomeno l’etnocidio o l’assimilazione (forzata e non).
Per i curdi rimane prioritario il fatto di resistere, sopravvivere. Sia agli eserciti statali che alle milizie parastatali, così come alle squadre della morte…talvolta anche ad altri curdi, più o meno collaborazionisti (vedi, talvolta, il PDK)***.
Viceversa, andrebbe apprezzato – e molto – il fatto che in un contesto come quello Medio orientale – e di questi tempi poi – qualcuno (se non un intero popolo, almeno una sua componente significativa) si auto-organizzi mettendo radicalmente in discussione le gerarchie consolidate (di stato, di classe, di genere…talvolta perfino l’antropocentrismo).
Gianni Sartori
**nota 2: Oltre che da Bookchin, Ocalan sarebbe stato influenzato dal pensiero di Braudel, Wallerstein, Mies, Foucault. Presumibilmente anche da Hanna Arendt (le cui posizioni sulla “Terza rivoluzione”- un riferimento alla Comune di Kronstadt del 1921 – convergono con quelle espresse da Bookchin) e dal Comandante Marcos. Quest’ultimo a sua volta influenzato dal situazionismo di Guy Debord che – lo ricordava la figlia – fu tra coloro (cita anche Herbert Marcuse, Daniel Cohn-Bendit, Huey Newton…) che con Bookchin ebbero uno scambio proficuo di idee e di reciproche contaminazioni.
#7NotePerUnaNuovaEuropa #EuskalHerria
“TIOCFAIDH ÁR LÁ – la mia Irlanda” – di Gianni Sartori

In Omaggio ai Soci2021 del Centro Studi Dialogo
“TIOCFAIDH ÁR LÁ – la mia Irlanda” – di Gianni Sartori
Abbiamo deciso di pubblicare questa raccolta di scritti di Gianni Sartori, frutto di decenni di viaggi sul territorio, di incontri e di interviste, per ricordare l’importanza della lotta del Popolo irlandese per l’affermazione del Diritto all’Autodeterminazione.
Tutti noi ci siamo entusiasmati e commossi per l’Epopea degli HungerStrikers, per le battaglie stradali a Belfast, per il sacrificio di tanti giovani che hanno messo da parte un’esistenza più facile e hanno dato tutto per la libertà della propria Terra e per l’unificazione delle Contee irlandesi sotto un’unica bandiera.
Una battaglia che non si è ancora conclusa, purtroppo, ma che dai recenti sviluppi post-Brexit può ricevere ulteriori spinte.
Per iscriversi o rinnovare l’iscrizione, contattare info@csdialogo.eu
