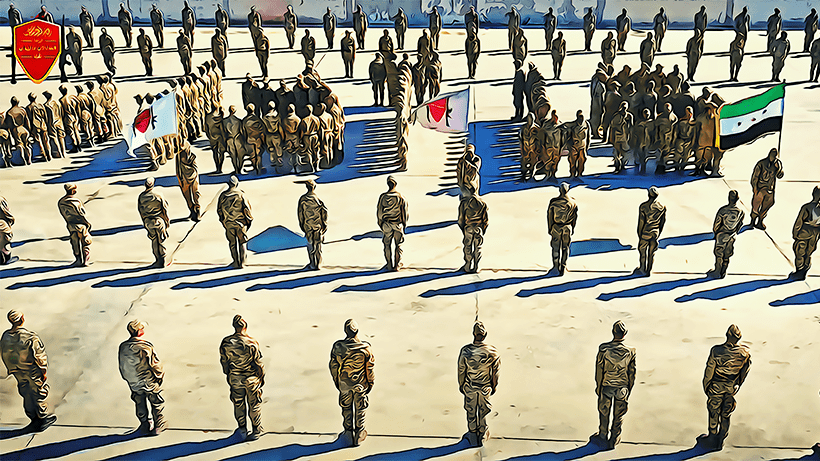Le operazioni dell’esercito e dell’aviazione turchi nel Kurdistan del Sud (Bashur, in territorio iracheno) mietono vittime sia tra i civili che tra i lavoratori dell’informazione. Per il recente duplice assassinio di due giornaliste curde si sono levate le proteste di associazioni e partiti, ma solo a livello locale. L’opinione pubblica internazionale seguita a volgere il capo altrove.
L’assassinio (il 23 agosto) per opera di un drone turco delle giornaliste curde Hero Bahaden (originaria di Batman, Bakur) e Gülistan Tara (nata a Sulaymaniyya) e il ferimento di altri sei giornalisti (tra cui molto gravemente Rêbîn Beki, supervisore di Chatr Production, ugualmente originario di Sulaymaniyya) a Said Sadiq (distretto di Seyidsadiq, non lontano da Sulaymaniyya- Silêmanî, nel Kurdistan iracheno) ha suscitato critiche e condanne da più parti: partiti politici, sindacati, associazioni…
Kemal Heme Reza (direttore di Chatr Production) ha dichiarato in conferenza stampa che a suo avviso “l’attacco è stato facilitato da un intervento locale e dai servizi di intelligence”. Ma soprattutto ha escluso quanto insinuavano alcuni media ossia che le due giornaliste fossero affiliate al PKK. Affermando con decisione che “tutti coloro che sono stati martirizzati e feriti in questo attacco sono giornalisti, senza alcun legame politico”.
Ricapitoliamo. Il 23 agosto un drone aveva bombardato (possiamo definirlo un attentato ?) un veicolo di Chatr Production mentre i giornalisti stavano realizzando un programma televisivo.
Niente di nuovo naturalmente. Da tempo nel Kurdistan del Sud (Bashur, in territorio iracheno) è in atto da parte di Ankara una campagna di attacchi con droni. Ufficialmente rivolti a presunti obiettivi legati al PKK.
Nel 2023 sono stati almeno 110, spesso con conseguenze mortali tra la popolazione e nella quasi totale indifferenza dell’opinione pubblica internazionale.
In un comunicato di IHD (Associazione dei Diritti Umani) si legge che “i lavoratori dei mezzi di comunicazione curdi continuano a rappresentare un obiettivo per le bombe turche”.
Definendo l’episodio “un massacro” e paragonandolo a quanto avveniva negli anni novanta quando “si cercava di farli tacere con gli arresti e con gli attacchi alle sedi dei giornali”.
Per cui IHD chiede “al governo iracheno, alla repubblica di Turchia e al governo regionale del Kurdistan di assumersi le proprie responsabilità portando gli assassini davanti alla giustizia”: Richiesta condivisibile, ma alquanto improbabile direi.
Un duro monito anche da parte dell’Assemblea delle Donne del Partito per l’Uguaglianza e la democrazia dei popoli (Partito DEM). L’attacco viene definito “deliberato e organizzato”, non certo un incidente. “Colpendo le donne giornaliste che denunciano gli attacchi contro il popolo curdo – hanno scritto – si vuole coprire i crimini di guerra commesse nella Regione Federale del Kurdistan. Obiettivo di tali azioni è quello di rafforzare la politica di annessione e occupazione”.
Ricordando alcuni precedenti come l’assassinio (da parte delle milizie filoturche) della giornalista Nagihan Akarsel a Sulaymaniyah. Concludendo che “i poteri imperiali e le strutture paramilitari che stanno dietro a tale attentato non potranno intimidire la lotta del popolo curdo, delle donne e nemmeno delle giornaliste”.
I responsabili “verranno smascherati e dovranno renderne conto”. Così come per le ricorrenti uccisioni di civili.
Significativo poi l’intervento di Ethem Barzani, uomo politico legato al clan Barzani (per ragioni di parentela) ma indipendente rispetto al PDK.
Convinto che “il martirio delle due giornaliste sia un crimine internazionale, contrario a tutte le norme e leggi relative ai diritti umani. Una violazione dei diritti dei cittadini e dei giornalisti”. Manifestando poi rammarico per le vicende del suo paese ”bombardato e occupato quotidianamente, dove dei bambini disarmati vengono martirizzati in un modo lontano da ogni logica umana”. Appellandosi quindi alla Comunità internazionale affinché “metta fine a queste violazioni che rappresentano una seria minaccia per la vita dei civili”.
Gianni Sartori